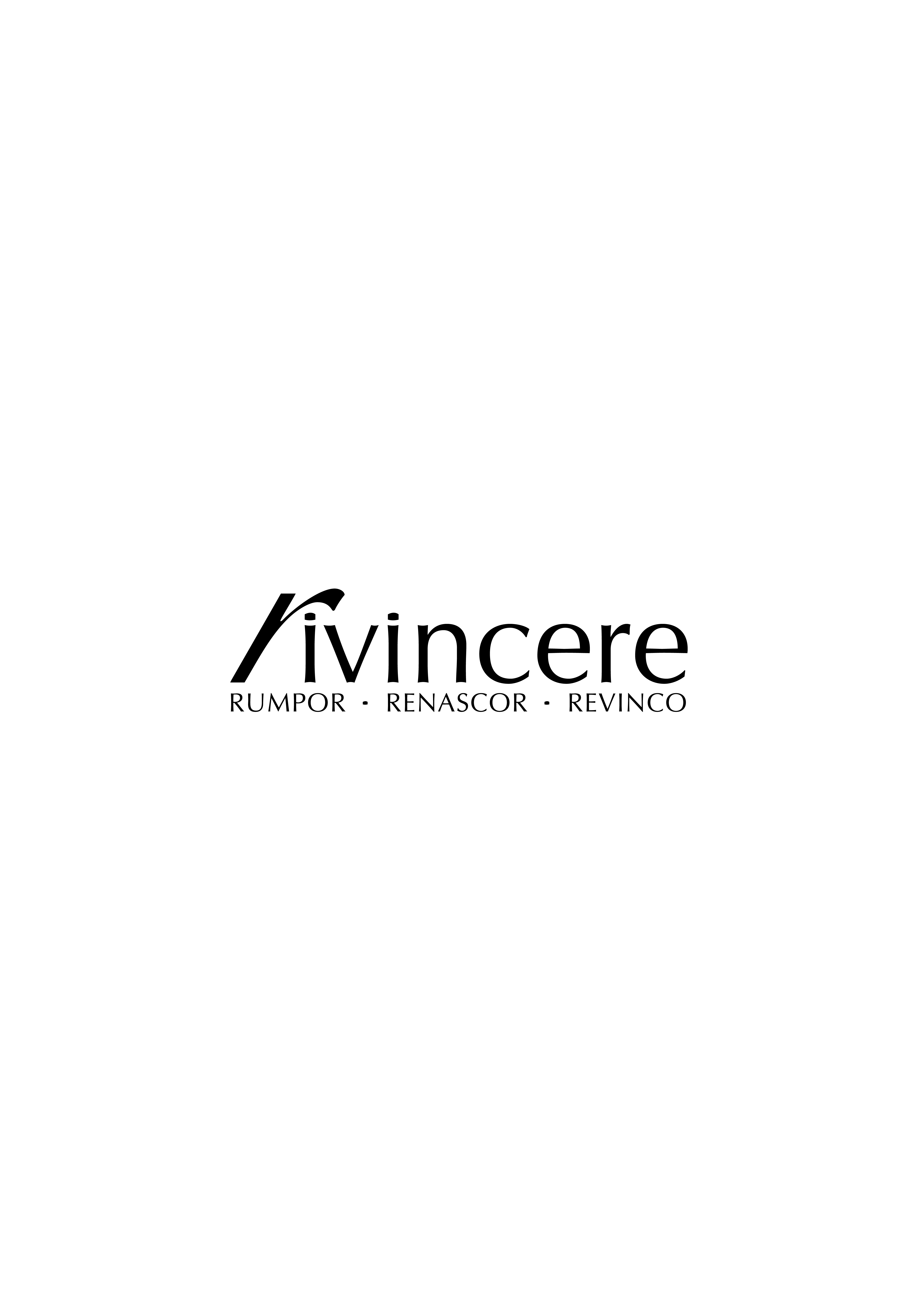Consuetudine giornalistica-editoriale tutta italiana, la Terza pagina ha origini più antiche di quelle che la vulgata ravvisa e racconta. «Per evitare di tramandare idee distorte e facili stereotipi», lo ha ribadito anche Paolo Di Stefano sul Corriere della Sera dell’11 dicembre 2021, e cioè in una data non certo casuale, come si capisce scorrendo l’incipit del pezzo:
«Una delle più resistenti bufale da manuale di storia (del giornalismo) vorrebbe che la famosa Terza pagina abbia una data di nascita inequivocabile: l’11 dicembre 1901, quando uscì sul «Giornale d’Italia» diretto da Alberto Bergamini una pagina, la 3, dedicata alla Francesca da Rimini di D’Annunzio che due giorni prima aveva inaugurato la stagione del Teatro Costanzi di Roma con Eleonora Duse. Questa cantilena è riuscita a far guadagnare a centinaia di candidati l’accesso nell’albo dei giornalisti, perché si trattava di una domanda ricorrente agli esami: quando è nata la Terza pagina?» Paolo Di Stefano, La Terza pagina tra bufale e stereotipi, in Corriere della Sera di sabato 11 dicembre 2021
Esperimenti e collaudi
Per la verità, una dozzina di anni prima dell’articolo firmato da Di Stefano, Michelangelo Bellinetti sapeva indirizzare correttamente quegli esaminandi che, ai corsi di Fiuggi, perfezionavano la loro preparazione in vista delle prove per l’ammissione all’elenco dei professionisti: l’insigne giornalista ricordava la brillante esperienza di Bergamini, vissuta nell’ultimo decennio dell’Ottocento, come direttore del Corriere del Polesine, a Rovigo, dove già aveva dedicato pagine monografiche alla cultura. Che la consuetudine della Terza pagina fosse stata collaudata nello scorcio conclusivo del diciannovesimo secolo, lo si capisce sfogliando i partenopei Corriere del Mattino e Giornale di Napoli, il Corriere letterario del torinese Corriere Nazionale, il genovese Colombo, il Corriere di Catania e la romana Tribuna. Cita questi precedenti, nella Storia del giornalismo italiano, edita dalla Utet, Ermanno Paccagnini, che chiarisce:
«I passaggi sono graduali, spesso di andata e ritorno, tanto da rendere l’invenzione della cosiddetta “Terza pagina” assai più problematica di quanto ha fatto la mitografia, che l’ha collocata all’11 dicembre 1901, quando, in occasione della prima assoluta della dannunziana Francesca da Rimini al Costanzi di Roma con la Compagnia della Duse il 9 precedente, Alberto Bergamini, fondatore e direttore del “Giornale d’Italia” incarica quattro diversi redattori di raccontare la fastosa serata sotto l’aspetto critico, scenografico, musicale e mondano» Ermanno Paccagnini, Il giornalismo dal 1860 al 1960, in G. Farinelli, E. Paccagnini, G. Santambrogio, A. I. Villa, Storia del giornalismo italiano: dalle origini ai giorni nostri, Torino, Utet, 1997, pagina 255 (Da un secolo all’altro)
D’Annunzio, Dante e Francesca
La fascinazione di quella mitografia era d’altronde inevitabile, considerando il lustro dei personaggi in scena: «il vate» D’Annunzio, «la divina» Duse, il Sommo Poeta e demiurgo della lingua italiana, Dante, e la protagonista di uno dei canti più celebri della sua Comedìa. Con questo poker d’assi in mano, il lungimirante Bergamini ha fatto saltare il banco, avvolgendo nell’aura del mito la Terza pagina, di cui sempre ha rivendicato con orgoglio la primogenitura:
«L’ampia relazione della agitata serata occupò una pagina che aveva un grosso titolo disteso su tutte le colonne: una intera pagina allora inconsueta, che mi parve signorile, armoniosa e mi suggerì l’idea di unire sempre, da quel giorno, la materia letteraria, artistica e affine, in una sola pagina, distinta, se non proprio avulsa dalle altre: come una oasi fra l’arida politica e la cronaca nera. E fu la “terza pagina”: dapprima incerta, indi migliorata e raffermata: finché pervenne ad essere la doviziosa “terza pagina” odierna, allettatrice per le sue rubriche letterarie artistiche mondane, per la varia collaborazione di sceltissimi scrittori, per le corrispondenze anche dall’estero che narrano le bellezze e i costumi di lontani paesi: e per le radianti molteplici leggiadre fotografie della grazia femminile in vario modo sorridenti.
Oggi la “terza pagina” è una istituzione: i lettori la aspettano con desiderio ogni giorno; per molti di essi, è la più gradevole» Alberto Bergamini, Nascita della «Terza pagina», uscito in Nuova Antologia, nel novembre del 1955, e quindi ripubblicato in Enrico Falqui, Nostra “Terza pagina”, Roma, Editrice Nanni Canesi, 1964, da cui è tratta la citazione (vedi pagina 253)
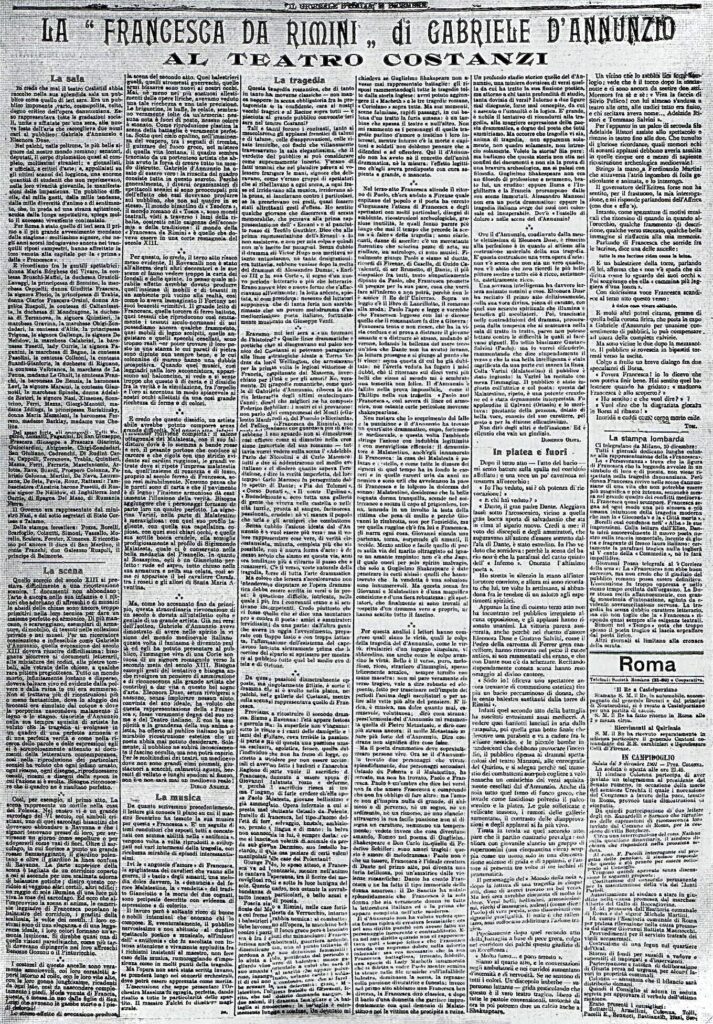
Un’«oasi nel «salotto buono»
Bergamini sottolinea così la “terzietà” di questa pagina che, «avulsa dalle altre», è «come una oasi fra l’arida politica e la cronaca nera». Insomma, un luogo a parte, una zona quasi protetta, o, se si preferisce, «il salotto buono del giornale», come la battezzò Aldo Palazzeschi, precisando che «bisogna pulirsi i piedi per entrarci», e definendo anche le altre stanze: «La prima è la camera da letto: “per non dormire”; e l’ultima, la stanza di sgombero. Quella dedicata allo sport, la camera da bagno; e il gabinetto, quella della cronaca cittadina». Un «salotto buono» che è stato ben arredato con i nomi più illustri della cultura italiana:
«La Terza pagina era il luogo d’incontro tra giornalisti, romanzieri, poeti e critici, e il canale attraverso il quale un paese ancora dominato dall’analfabetismo veniva a contatto con i suoi scrittori. Per i letterati di grido era una palestra e una vetrina insostituibile: il poeta Francesco Pastonchi mandava i suoi elzeviri al Corriere accompagnati da una nota per l’ufficio diffusione: “Aumentare sensibilmente la tiratura”. Luigi Pirandello non avrebbe forse mai prodotto le sue Novelle per un anno se il redattore del Corriere non gli avesse imposto dei tagli tipografici. Per i più giovani e squattrinati costituiva anche una preziosa, se non l’unica fonte di sostentamento: come confessò una volta Emilio Cecchi, “fu la sola borsa di studio accessibile per noi” e Montale ammetteva che senza quelle collaborazioni sarebbe morto di fame» Riccardo Chiaberge, La Cultura, in Il quotidiano in classe, Educazione alla cittadinanza a cura dell’Osservatorio Permanente Giovani-Editori, La Nuova Italia, Firenze, 2007, pagine 37-38
«Il salotto superfluo»
 Con lo scorrere del “secolo breve”, la Terza pagina si sfilaccia e, col lento ma progressivo sopirsi dei suoi fasti, viene messa in discussione. Già negli anni Sessanta del Novecento, Nello Ajello parla dell’«indecorosa agonia» di «quel prodotto della disoccupazione letteraria» che, precisa Alberto Arbasino, «fu l’elzevirismo, quella sterile pavana di mandarini mediocri», come si legge nel suo durissimo atto d’accusa uscito sul Giorno di mercoledì 7 novembre 1962. Il titolo dell’articolo – «Il salotto superfluo» (vedi foto) – è la stroncatura di quel «salotto buono» che, secondo l’autore, non è stato solo inutile ma perfino dannoso e quella «oasi fra l’arida politica e la cronaca nera» ha stagnato a tal punto da diventare una palude:
Con lo scorrere del “secolo breve”, la Terza pagina si sfilaccia e, col lento ma progressivo sopirsi dei suoi fasti, viene messa in discussione. Già negli anni Sessanta del Novecento, Nello Ajello parla dell’«indecorosa agonia» di «quel prodotto della disoccupazione letteraria» che, precisa Alberto Arbasino, «fu l’elzevirismo, quella sterile pavana di mandarini mediocri», come si legge nel suo durissimo atto d’accusa uscito sul Giorno di mercoledì 7 novembre 1962. Il titolo dell’articolo – «Il salotto superfluo» (vedi foto) – è la stroncatura di quel «salotto buono» che, secondo l’autore, non è stato solo inutile ma perfino dannoso e quella «oasi fra l’arida politica e la cronaca nera» ha stagnato a tal punto da diventare una palude:
«La terza pagina non sarebbe mai dovuta esistere; o almeno, mai come compiaciuta esibizione di riboboli e princisbecchi, come “salotto bòno della stampa italiana”, cinicamente indifferente ai veri problemi del tempo; mai come diseducatrice sistematica di generazioni di sprovveduti lettori, incantati con trucchi lessicali di bassa forza e distratti da futili descrizioni di fiumi esotici e di voli di galli cedroni, invece d’esser trascinati col naso sul “punctum dolens”, come si fa coi cuccioli che sporcano in casa, e come dovrebbe esser compito di ogni giornalismo degno. L’alibi del fascismo anche qui conta proprio niente, perché anche qui finisce la guerra e niente cambia; e mentre nel mondo cambia tutto, e l’Italia ci si trasforma sotto gli occhi, e in ogni paese i giornali responsabili si sforzano di intendere il senso dei fenomeni, interpretando con ogni mezzo l’attualità culturale, politica, economica, sociologica, artistica, tecnica, la palude della terza pagina continua a produrre con indifferenza apologhi digestivi e favolette antinevralgiche, ad opera di praticoni crepuscolari che frequentano l’Evasivo o l’Edificante o l’Esotico…» Alberto Arbasino, Il salotto superfluo, in Il Giorno di mercoledì 7 novembre 1962, pagina 5
Diseducazione sistematica
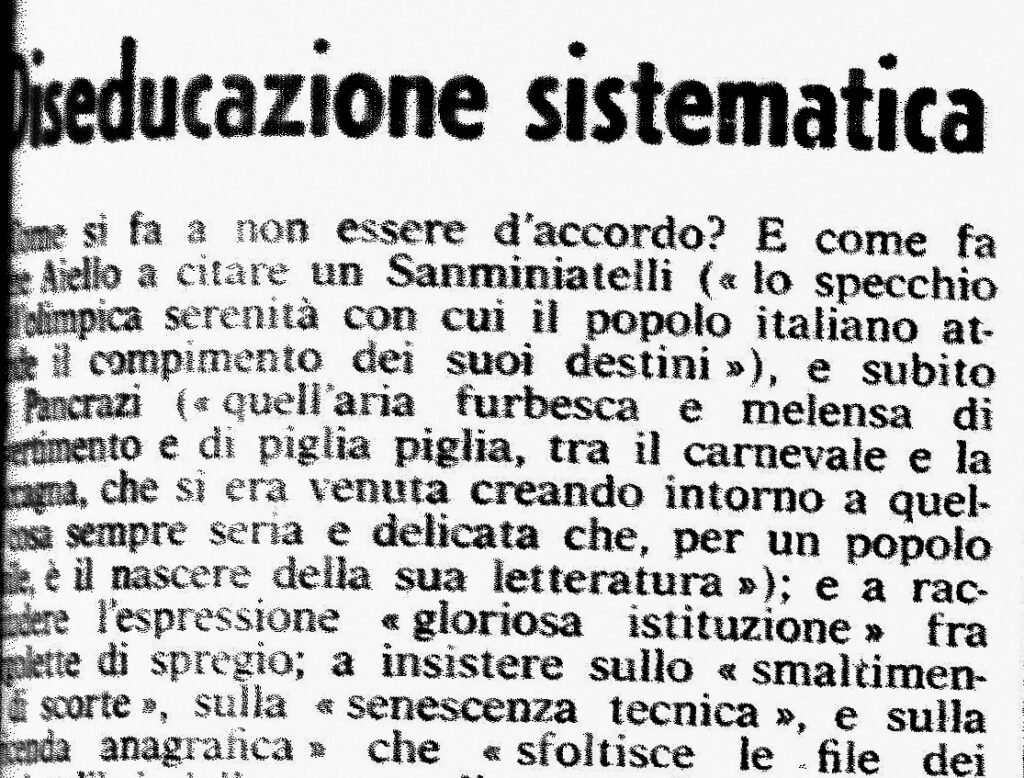
L’etichetta «diseducatrice sistematica di generazioni di sprovveduti lettori», affibbiata da Arbasino alla Terza pagina, e rimarcata anche dal titolino «Diseducazione sistematica» (vedi foto), è attuale oggi non considerando quei contenitori culturali, spesso spazi “terzi”, a sé stanti, per lo più inserti dei giornali, che propongono, con rigore filologico, degni approfondimenti su autori e opere artistiche. Semmai, la cattiva educazione viene impartita dal sistema mediatico globale, asservito al «pensiero unico» neoliberista: «la pensée unique», categoria ben studiata da uno dei massimi pensatori del ventesimo secolo, Pierre Bourdieu, illuminante anche nel definire la cultura come «strumento di libertà che presuppone la libertà» (Post Scriptum, Per un corporativismo dell’universale in Pierre Bourdieu, Le regole dell’arte, Genesi e struttura del campo letterario, traduzione di Anna Boschetti e Emanuele Bottaro, Il Saggiatore, Milano, 2022, pagina 428). 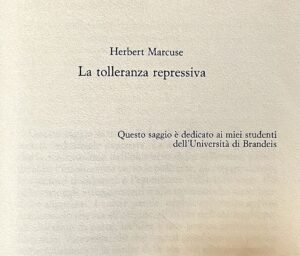
Se il «pensiero dominante» aveva liquidato il «pensiero antagonista» attraverso le forme di «tolleranza repressiva», puntualmente descritte da Herbert Marcuse nell’omonimo saggio del 1965, dedicato ai suoi studenti dell’Università di Brandeis, il «pensiero unico» non ammette dialettica. Non esiste contraddittorio perché ogni idea alternativa appare inconcepibile, ogni orientamento divergente viene neutralizzato preventivamente e ogni prospettiva non allineata finisce per essere programmaticamente castrata.
Logotomia per glossectomizzati
Il «pensiero unico» attua la «neolingua» preconizzata dal preveggente George Orwell in «1984», romanzo che nel lontano 1949 si era rivelato profetico. Il «newspeak» attuale, intessuto degli anglicismi imperanti nel globalismo economico, si traduce in automatismo mentale, riverberando comodi surrogati di pensiero per chi non ha voglia di soppesare il proprio presente, sottoponendolo a riflessione critica. La cesoia della censura realizza l’ideale glossectomia di chi non è disposto ad accettare il sistema di interdizioni prescritto dal «politicamente corretto», la cui principale caratteristica è «ovviamente quella di impedire che se ne parli in modo non programmaticamente politicamente corretto. È questa una caratteristica di tutti i tabù, per cui parlarne è già violare un tabù…» (Costanzo Preve, Elementi di politicamente corretto, Studio preliminare su un fenomeno ideologico sempre più invasivo, Editrice Petite Plaisance, Pistoia, 2020, pagina 27).
Le vigliacche liste di proscrizione vergate dal politicamente corretto includono, oltre alle parole, i pensieri a essi legati, per cui la metaforica glossectomia diventa una reale «logotomia», cioè recisione del «λόγος» («logos»), la «parola» che è anche «pensiero» e «ragione».
Resezione del non conforme
Con inaudita ignoranza, si violentano gli «auctores» e le «auctoritates» della letteratura, dell’arte, della filosofia; si ostracizza chiunque sia sgradito al «pensiero unico» e al «politicamente corretto», non importa se classico o contemporaneo; si cassano opere immortali attraverso la cosiddetta «cancel culture», letteralmente «cultura della cancellazione». Ma, come ricordava Bourdieu, la cultura è «strumento di libertà che presuppone la libertà» e, dunque, non può essere tale la «cancel culture», piuttosto incolta presunzione col culto dell’aferesi, schiava di oscurantismo fobico rivolto al passato. Chi pretende di operare questa crudele resezione, rimuovendo i monumenti della tradizione letteraria, artistica, filosofica, solo perché non conformi alla propria visione del mondo, senza neppure riconoscerne il valore intrinseco, non genera di certo cultura. La rimozione praticata dalla «cancel culture», infatti, implica il non sapere e semina dunque ignoranza che, come dice la parola stessa, è proprio la condizione di chi non ha conoscenza o notizia di qualcosa (quello che appunto deve essere cancellato). Per giudicare criticamente occorre, viceversa, conoscere, ponderare con attenta riflessione anche ciò che appare discordante, confrontandosi e dialogando con esso.
L’anti-filologia
Tutta l’arte – pure quella non combaciante con i nostri ideali – è un patrimonio da custodire, ma, purtroppo, questo assunto irrefutabile non è presente alla «cancel culture», opposta così all’ecdotica, quella «ἔκδοσις» («èkdosis») che significa «consegna», «restituzione», e corrisponde al latino «editio», «pubblicazione». Divenuta rigorosa disciplina (a battezzarla «ecdotique» fu dom Henri Quentin, come ricordava Gianfranco Contini nel suo Breviario di ecdotica, pubblicato la prima volta nel 1986 da Riccardo Ricciardi Editore), ci consegna e restituisce (sulle orme del verbo «ἐκδίδωμι», «ekdìdomi») i testi antichi nella veste più vicina all’originale. La filologia come disciplina storica si preoccupa proprio di preservare l’integrità del messaggio che arriva dal passato, ne ricostruisce l’interezza, nel pieno rispetto della volontà dell’autore, e ce lo recapita consentendoci di avviare il dialogo e l’indispensabile relazione critica con esso. Al contrario, la «cancel culture», quando non manda direttamente al macero, emenda intervenendo, senza scrupoli, sui testi: corregge gli autori, senza rispetto della loro volontà e del loro stile, rattoppando con le scabre pezze del «politicamente corretto». È l’anti-filologia.
«Aletheia», «Parresia» e comprensione
Nascondere quello che è scomodo alla propria Weltanschauung, relegandolo alla negazione dell’oblio imposto, è un vile atto di comodo, che va contro la verità, quella verità chiamata in greco «ἀλήθεια» («alètheia»): l’alfa privativa (α-) precede la radice λαθ- (lath-) del verbo «λανθάνω» («lanthano»), che significa «rimango nascosto, occulto, ignoto; mi celo, nascondo; sfuggo l’osservazione». Proprio la Grecia ci ha insegnato a disvelare, a dire tutto: nella culla della filosofia, già a partire dal quinto secolo prima di Cristo, si praticava la «παρρησία» («parresìa») e l’etimologia di questa parola, derivante da «πᾶς, παντός» («pas, pantòs») – «tutto» – e «ῥῆσις» («rhesis») – «parola, discorso» – fa capire che per andare incontro alla verità è indispensabile la libertà di parola, in modo da dire tutto, senza omissioni. Solo la piena conoscenza consente l’espressione di un giudizio critico e l’incontro con autori non corrispondenti ai nostri valori è sempre un’imperdibile occasione di crescita. Condannarli all’oblio fa male a tutti, in particolare al nostro intelletto, sottratto all’utile confronto. È un invito alla saggezza comprenderli, cioè cercare di capire il loro pensiero profondo, le loro intenzioni, il loro carattere spirituale, quello della cultura che hanno espresso nell’età in cui sono vissuti. Ma occorre comprenderli pure nel senso primo del verbo, che equivale a «contenere in sé», a «racchiudere», ad «abbracciare». È il «prendere insieme» suggerito proprio da un filologo, Maurizio Bettini, nel suo Chi ha paura dei Greci e dei Romani? (Einaudi, Torino, 2023), con questa fondamentale specificazione: «tenendo così vive quella epistéme, quel nóus, quella phrónesis a cui aspirava Platone nella pratica del dialogo» (pagina 61).
«Ginnasio di pensiero»
Alle idee si ribatte con le idee e, appunto, con il dialogo: il confronto è necessario per «aprire la mente» e costituisce quel «ginnasio di pensiero» indispensabile per tenere vivi i muscoli dell’intelletto, allenandoli alla riflessione critica, e scongiurandone l’atrofia, rischio sempre più incombente nell’era dell’omologazione di massa. Per uscire dall’antro del «pensiero unico» e per evitare di imbattersi nei vicoli ciechi del «politicamente corretto» e della «cancel culture», basta acquisire piena coscienza di sé e del proprio rapporto con il mondo, (ri)trovando il coraggio di pensare liberamente. Così come hanno saputo fare i quattro ragazzi a cui è dedicata la foto che non solo identifica la Terza pagina di Rivincere ma che è il vero manifesto di questo verbo. Immortali come Zéro de conduite, il film di cui sono i protagonisti, hanno un padre altrettanto immortale: il regista Jean Vigo, vissuto neppure trent’anni (dal 26 aprile del 1905 al 5 ottobre del 1934) ma capace di eternarsi attraverso la sensibilità del suo inesauribile genio poetico e incidere profondamente sulla storia del cinema. Immortali e coraggiosi, li conosciamo con i loro cognomi, perché è così che ci si chiama in collegio: Caussat, Colin, Bruel e Tabard non vivono però con rassegnazione il loro internato nel tetro istituto in cui il preside e tutti i sorveglianti (tranne il giovane Huguet, nuovo arrivato) agiscono in preda alla loro alienazione, trasformando le regole in oppressivi riti svuotati di senso.
La parola sublime e necessaria
«Condannati alla volgarità di un luogo comune che vuole l’adolescenza subordinata e passiva di fronte a un mondo degli adulti che va imitato e “reificato” maldestramente nell’immaginario dei suoi vizi e nelle ossessioni piccole e grandi che lo inquinano» (Maurizio Grande, Jean Vigo, Il Castoro Cinema, La Nuova Italia, Firenze, aprile 1979, pagine 66-67; la citazione si trova invece a pagina 61 nella riedizione dello stesso libro datata 2004), i ragazzi sanno tuttavia preservare intatta la loro anima e hanno la forza di ribellarsi. Risuona forte, per ben due volte nel film, «le plus beau mot peut-être qu’un Français ait jamais dit ne peut lui être repete». «La parola forse più bella che un francese abbia mai detto e non può essergli ripetuta» perché «è vietato depositare il sublime nella storia» («Défense de déposer du sublime dans l’histoire»). Così scrive Victor Hugo nel capitolo dei Miserabili dedicato a Cambronne, l’unico vincitore a Waterloo:
«L’homme qui a gagné la bataille de Waterloo, ce n’est pas Napoléon en déroute, ce n’est pas Wellington pliant à 4 heures, désespéré à 5, ce n’est pas Blücher, qui ne s’est point battu; l’homme qui a gagné la bataille de Waterloo, c’est Cambronne. Foudroyer d’un tel mot le tonnerre qui vous tue, c’est vaincre.
Faire cette réponse à la catastrophe, dire cela au destin, donner cette base au lion futur, jeter cette réplique à la pluie de la nuit, au mur traître de Hougomont, au chemin creux d’Ohain, au retard de Grouchy, à l’arrivée de Blücher, être l’ironie dans le sépulcre, faire en sorte de rester debout après qu’on sera tombé, noyer dans deux syllabes la coalition européenne, offrir aux rois ces latrines déjà connues des Césars, faire du dernier des mots le premier, en y mêlant l’éclair de la France, clore insolemment Waterloo par le Mardi gras, compléter Léonidas par Rabelais, résumer cette victoire dans une parole suprême impossible à prononcer, perdre le terrain et garder l’histoire, après ce carnage avoir pour soi les rieurs, c’est immense.
C’est l’insulte à la foudre. Cela atteint la grandeur eschylienne.
Le mot de Cambronne fait l’effet d’une fracture. C’est la fracture d’une poitrine par le dédain; c’est le trop-plein de l’agonie qui fait explosion» Victor Hugo, Les Misérables, Deuxième partie, Cosette, Livre I, chapitre XV, Cambronne
«L’uomo che ha vinto la battaglia di Waterloo non è Napoleone in rotta, non è Wellington in ritirata alle quattro, disperato alle cinque, non è Blücher che non si è battuto; l’uomo che ha vinto la battaglia di Waterloo è Cambronne.
Fulminare con una parola simile l’uragano che vi uccide, è vincere.
Rispondere così alla catastrofe, dire questo al destino, donare questo piedistallo al leone futuro, lanciare questa replica alla pioggia della notte, al muro traditore di Hougomont, alla strada incassata di Ohain, al ritardo di Grouchy, all’arrivo di Blücher, essere l’ironia nel sepolcro, fare in modo di restare in piedi dopo che si sarà caduti, annegare in due sillabe la coalizione europea, offrire ai re quelle latrine già note ai Cesari, trasformare l’ultima parola nella prima mescolandovi il lampo della Francia, chiudere insolentemente Waterloo col martedì grasso, completare Leonida con Rabelais, riassumere quella vittoria in una parola suprema impossibile a pronunciarsi, perdere il terreno e conservare la storia, dopo quel massacro gettare il ridicolo sull’avversario, è immenso.
È l’insulto alla folgore. Raggiunge la grandezza eschilea.
La parola di Cambronne fa l’effetto di una frattura. È la frattura di un petto per lo sdegno; è l’eccesso dell’agonia che esplode»
Tabard-Cambronne
A fare eco al generale Pierre-Jacques-Étienne Cambronne, «titano fra i giganti» («parmi tous ces géants, il y eut un titan», scrive sempre Hugo), c’è in Zéro de conduite un ragazzino dolce e delicato, timido e irrequieto: Réne Tabard. È lui il nuovo arrivato in collegio, non tenuto in considerazione da Caussat e Colin, che lo ritengono «une fille» (potremmo dire «una femminuccia»). È anche il “sorvegliato speciale” del preside, che lo manda a chiamare lanciando insinuazioni morbose sulla sua amicizia con Bruel. Ma Tabard sta per indossare i panni del condottiero, trascinando i compagni verso la rivolta, necessaria per vincere l’asfissia suscitata da un ambiente cupo moralmente e intellettualmente.
Nell’aula di chimica, Tabard è seduto al suo banco in prima fila, immobile, con la testa china fra le mani. Il laido professor Viot gli si presenta davanti, accarezzandogli la testa e chiedendogli: «Eh bien! Mon petit garçon, tu ne prends pas de notes ce matin?» («E allora! Mio caro, non prendi appunti questa mattina?»).
Il laido professor Viot gli si presenta davanti, accarezzandogli la testa e chiedendogli: «Eh bien! Mon petit garçon, tu ne prends pas de notes ce matin?» («E allora! Mio caro, non prendi appunti questa mattina?»).  Il ragazzo si scosta bruscamente, comincia a scrivere, allungando il braccio davanti al quaderno, appena aperto, come a volersi proteggere, ma l’insegnante non demorde con la sua mano grassa e unta.
Il ragazzo si scosta bruscamente, comincia a scrivere, allungando il braccio davanti al quaderno, appena aperto, come a volersi proteggere, ma l’insegnante non demorde con la sua mano grassa e unta.  Questa volta ne approfitta per accarezzare morbosamente la mano sinistra di Tabard, che indispettito la ritrae, pretendendo di essere lasciato immediatamente: «Ah, laissez-moi !…». Il professore ribatte, fra il conciliante e il minaccioso: «Ah mon p’tit, je n’te dis que ça…» («Ah, piccolo mio, ti dico solo questo…»). A questo punto risuona forte la parola-chiave di Cambronne, che, liberatrice, sgorga impetuosa dalla voce ferma del giovane collegiale:
Questa volta ne approfitta per accarezzare morbosamente la mano sinistra di Tabard, che indispettito la ritrae, pretendendo di essere lasciato immediatamente: «Ah, laissez-moi !…». Il professore ribatte, fra il conciliante e il minaccioso: «Ah mon p’tit, je n’te dis que ça…» («Ah, piccolo mio, ti dico solo questo…»). A questo punto risuona forte la parola-chiave di Cambronne, che, liberatrice, sgorga impetuosa dalla voce ferma del giovane collegiale:
«Je vous dis merde!»
 Necessaria come o più del pane, come o più dell’aria, questa parola di ribellione alla volgarità di un professore sporco anche moralmente, è ripetuta già nella scena successiva, davanti al preside, minuscolo non solo nell’aspetto. Questa volta, i ragazzi si trovano nell’aula studio con il buon sorvegliante Huget. All’improvviso entra il direttore, seguito dal professor Viot e dagli altri due sorveglianti, con l’intento di anestetizzare il coraggioso ribelle attraverso il suo soffocante predicozzo:
Necessaria come o più del pane, come o più dell’aria, questa parola di ribellione alla volgarità di un professore sporco anche moralmente, è ripetuta già nella scena successiva, davanti al preside, minuscolo non solo nell’aspetto. Questa volta, i ragazzi si trovano nell’aula studio con il buon sorvegliante Huget. All’improvviso entra il direttore, seguito dal professor Viot e dagli altri due sorveglianti, con l’intento di anestetizzare il coraggioso ribelle attraverso il suo soffocante predicozzo:
«Tabard! Mon p’tit, le conseil de discipline, n’est-ce pas, a consenti, sous la forte pression de ton professeur bienveillant, vous êtes magnanime Monsieur Viot, a consenti, dis-je, par considération pour ta famille, par bonté pour toi et à l’occasion de notre chère fête qui sera célébrée demain, à te pardonner, mais, n’est-ce pas, du reste tu es venu spontanément, si j’ose dire, me prier d’accepter tes excuses qui ne sauraient avoir de valeur que formulées en public et devant tous tes camarades… nous attendons… eh bien dis-nous ce que tu veux nous dire… dis-nous ce que tu as envie de dire, allons!…»
«Tabard! Mio piccolo, il consiglio di disciplina, è vero, ha acconsentito, sotto la forte pressione del tuo benevolo insegnante, lei è magnanimo Signor Viot, ha acconsentito, dico, per riguardo alla tua famiglia, per bontà nei tuoi confronti e in occasione della nostra cara festa che sarà celebrata domani, a perdonarti, ma, è vero, del resto sei venuto spontaneamente, se oso dire, a pregarmi di accettare le tue scuse che possono avere valore solo se formulate in pubblico e davanti a tutti i tuoi compagni… Noi le attendiamo… eh beh dicci cosa vuoi dirci… dicci cosa hai voglia di dire, andiamo!…»  Tabard difende ancora una volta la sua dignità, sbugiardando il preside, perché non è mai andato da lui a chiedere scusa e a mendicare il perdono del laido professor Viot. Il ragazzo non si piega con resiliente rassegnazione e, anzi, guarda negli occhi l’autorità, a cui sbatte in faccia il suo disprezzo:
Tabard difende ancora una volta la sua dignità, sbugiardando il preside, perché non è mai andato da lui a chiedere scusa e a mendicare il perdono del laido professor Viot. Il ragazzo non si piega con resiliente rassegnazione e, anzi, guarda negli occhi l’autorità, a cui sbatte in faccia il suo disprezzo:
«Monsieur le Professeur, je vous dis merde!»
 Fuori dalla caverna verso il cielo
Fuori dalla caverna verso il cielo
La frattura non si può ricomporre. La rivolta scoppia di sera, nel dormitorio, dove Tabard, il “sorvegliato speciale” del preside, considerato «una fille» dai compagni, ha ormai in sé il carisma per calamitare gli ammutinati, stretti intorno a lui, che li guida tenendo in mano il «Jolly Roger», la bandiera, con il teschio e le tibie incrociate, dei pirati. Con voce squillante, il ragazzo legge il suo proclama:
«La guerre est déclarée!
À bas les pions! À bas les punitions!
Vive la révolte! La liberté ou la mort!
Plantons notre drapeau sur le toit du collège.
Demain, tous debout avec nous.
Nous jurons de bombarder à coups de vieux bouquins, de vieilles boîtes de conserve, de vieilles godasses – munitions cachées dans le grenier – les vieilles têtes de pipe des jours de fête…
En avant! En avant!»
«La guerra è dichiarata! Abbasso i sorveglianti! Abbasso le punizioni! Viva la rivolta! Libertà o morte! Piantiamo la nostra bandiera sul tetto del collegio. Domani, tutti in piedi con noi. Giuriamo di bombardare a colpi di vecchi libri, di vecchie scatole di conserva, di vecchie scarpe – munizioni nascoste nella soffitta – le vecchie teste di pipa dei giorni di festa… Avanti! Avanti!»  Non è solo l’insurrezione che immaginavano, per opporsi ai continui e ingiusti «zero in condotta», gli altri collegiali. Perché è la rivolta piena coltivata e maturata nel profondo dell’anima di Tabard, consapevole di trovarsi nella cieca «caverna platonica» che condanna le coscienze all’asservimento, fino al loro totale annientamento. Come scrive magistralmente Maurizio Grande, nel Castoro Cinema menzionato in precedenza (vedi pagina 84 dell’edizione 1979 o pagina 79 nella riedizione 2004), è:
Non è solo l’insurrezione che immaginavano, per opporsi ai continui e ingiusti «zero in condotta», gli altri collegiali. Perché è la rivolta piena coltivata e maturata nel profondo dell’anima di Tabard, consapevole di trovarsi nella cieca «caverna platonica» che condanna le coscienze all’asservimento, fino al loro totale annientamento. Come scrive magistralmente Maurizio Grande, nel Castoro Cinema menzionato in precedenza (vedi pagina 84 dell’edizione 1979 o pagina 79 nella riedizione 2004), è:
«… una negazione dell’autorità nella sua profonda radice di “corruzione” che conduce alla nullificazione dell’individuo, fino a renderlo complice di manie morbose. La rivolta di Tabard appare così un tentativo di salvezza, ultima e unica possibilità di salvarsi dalla corruzione con una scelta radicale, e non tanto la soddisfazione di un mito, del mito anarchico della “rivolta per la rivolta”»
Dal buio (soprattutto morale) dell’antro-collegio alla luce dell’esterno il passo è obbligato e Vigo lo descrive con l’abbagliante poesia di quelle immagini rivelatrici, che sono una bussola da avere sempre sotto gli occhi.  Invitano a uscire dalla caverna in cui si attua l’omologazione delle coscienze, in cui si genera «il pensiero unico» e quel vuoto culturale che inebetisce l’uomo, privandolo della sua essenza di «animale pensante» dotato di logos e capace di formulare criticamente i propri pensieri. La salita sul tetto di Tabard, Bruel, Caussat e Colin, con cui si chiude il film, pone più in alto di tutti i quattro ragazzi, che sventolano la bandiera della libertà, come nel fotogramma-manifesto della Terza pagina di Rivincere. Per tornare a rivedere la luce della ragione bisogna saper ribellarsi, come ha fatto Tabard. La fine della pellicola culmina con i collegiali, ormai affrancati, che si fondono con il cielo:
Invitano a uscire dalla caverna in cui si attua l’omologazione delle coscienze, in cui si genera «il pensiero unico» e quel vuoto culturale che inebetisce l’uomo, privandolo della sua essenza di «animale pensante» dotato di logos e capace di formulare criticamente i propri pensieri. La salita sul tetto di Tabard, Bruel, Caussat e Colin, con cui si chiude il film, pone più in alto di tutti i quattro ragazzi, che sventolano la bandiera della libertà, come nel fotogramma-manifesto della Terza pagina di Rivincere. Per tornare a rivedere la luce della ragione bisogna saper ribellarsi, come ha fatto Tabard. La fine della pellicola culmina con i collegiali, ormai affrancati, che si fondono con il cielo:
«I quattro guadagnano il bordo del tetto e continuano ad agitare in aria le mani, come a dissipare una nebbia invisibile o accennando a nuotare nell’aria. Finché, in campo lunghissimo, li vediamo raggiungere il bianco del cielo nel quale si confondono» Maurizio Grande, Jean Vigo, Il Castoro Cinema, La Nuova Italia, Firenze, Aprile 1979, pagina 89 (pagine 84-85 della riedizione 2004)
 Apertura al contagio
Apertura al contagio
Questa pagina insegue proprio i ribelli di Zéro de conduite, film che fu addirittura vietato, fino al 1945, dalla rabbiosa e miope censura e poi, comunque, finì per essere pesantemente mutilato, proprio come è accaduto anche all’altro grande capolavoro di Vigo: L’Atalante.
Muovendo, dunque, contro la censura e, come ricordato prima, contro il «pensiero unico», il «politicamente corretto», «la cancel culture», l’omologazione di massa, ormai imperante a tutti i livelli, riguardando anche il gusto e il sapore (che è sapere), questo sito, questa Terza pagina e tutti i contenuti editoriali legati al marchio Rivincere, si aprono al contagio.
Luogo di incontro, dialogo e crescita, questo sito punta a stimolare la coscienza critica ed è rivolto a tutte le arti, con una serie di continue – non necessariamente contigue – contaminazioni. Crogiolo di differenti esperienze culturali e crocevia dove poter incontrare artisti, artefici, artigiani, pensatori, poeti, scrittori, questa Terza pagina è un punto di partenza e ripartenza verso saperi e sapori di luoghi diversi. È un’officina (ergasterio) che coltiva il seme della cultura nel terreno fecondo della relazione dialogica e non smette mai di porsi domande, senza paura di mettersi in discussione. Area rigorosamente contaminata, aspetta soprattutto il vostro contributo: contagiate Rivincere condividendo qui le vostre idee, in modo da aprire quel dialogo che è sempre fonte di accrescimento e rinnovamento.